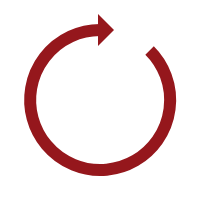DONNE, LESBICHE, TRANS: SE TOCCANO UNA, RISPONDIAMO TUTTE
Il racconto di Natalia di Marco, da “Non una di meno” in Argentina allo sciopero globale delle donne
Trascrizione dell’intervento tenuto per “Uteri senza Frontiere”, a cura di Orlando e della Favolosa Coalizione (Bologna, 16-17/12/2016).
Traduzione a cura di Susanna De Guio.
Sono Nati Di Marco, militante femminista, anticapitalista, docente, comunicatrice popolare dell’Argentina, di Cordoba. In relazione alla lotta per il diritto a decidere, a progettare sui nostri corpi e le nostre vite, in Argentina e in tutta l’America Latina abbiamo un’importante tradizione di lotta. Siamo Paesi che hanno attraversato secoli segnati dalle dittature militari, con una repressione e una violenza molto importanti, e che per molto tempo hanno fatto sì che si pensasse che le lotte delle donne e delle femministe dovevano occupare luoghi secondari nelle rivendicazioni dei movimenti sociali e popolari. Tuttavia, molte compagne che hanno militato negli anni ’70, di sinistra, rivoluzionarie, e che sono state esiliate durante la dittatura in Argentina, e in altri Paesi, si sono nutrite, in esilio e in Europa, di altre esperienze femministe, e sono tornate negli anni ’80 con un enorme impeto di trasformazione. Questo impeto in Argentina si è plasmato in quel che è stato il primo incontro nazionale delle donne, che si è convocato a Buenos Aires nel 1984. Oggi siamo già arrivati a 30 incontri nazionali, senza interruzione, anno dopo anno, in diverse città, e che sono spazi in cui confluiscono decine di migliaia di donne, lesbiche, trans, travestite, da diversi luoghi del Paese, ma anche dal resto del continente e da altri luoghi del mondo.
Questa pratica di incontro, di costruzione collettiva, è riuscita a generare e ad aprire spazi di dialogo che hanno dato luogo alla creazione di campagne tanto importanti come è stata la campagna nazionale per il diritto all’aborto legale, sicuro e gratuito in Argentina, così come anche quella contro la violenza sulle donne. In questo senso noi pensiamo che questa questione degli incontri nazionali delle donne si intrecci con le pratiche ancestrali che hanno costruito le donne del continente, di formare reti solidali e tra amiche, tra vicine di casa e di quartiere, per appoggiarci, per accompagnarci di fronte alle situazioni più dure. Come per esempio quando decidiamo di interrompere una gravidanza in un contesto di clandestinità. Ma anche per formare reti tra amiche e vicine, tra compagne, di fronte a situazioni di violenza che attraversiamo quotidianamente come donne.
Queste forme di organizzazione e di risposta, profondamente femministe, costruiscono a partire dall’orizzontalità, dall’affetto e dal corpo, e non solamente a partire dalle categorie razionali, politicizzano tutte le altre pratiche, confluendo in quelli che sono gli incontri nazionali delle donne. Nel nostro Paese queste campagne sono riuscite a generare un avanzamento del consenso sociale intorno al diritto all’aborto, nonostante continui a essere clandestino. In realtà solamente in tre situazioni è legale in Argentina:
– in caso di pericolo di salute o di vita della donna gestante;
– in caso di stupro;
– in caso di abuso di una donna che è dichiarata incapace.
A eccezione di questi tra casi in Argentina non si può accedere all’aborto legale. Tuttavia, nonostante il conservatorismo dei giudici, dei medici, di tutte le corporazioni e dei nostri governi, perché finora nessuno si è pronunciato a favore della legalizzazione di questo diritto, che è così importante per le donne, a livello sociale si sono aperte enormi brecce nel dibattito, con la possibilità di aprire il dibattito per il diritto all’aborto delle donne. Oggi la campagna è composta da sindacati, organizzazioni studentesche, organizzazioni femministe di donne, ovviamente, ma anche movimenti territoriali di tutti i tipi, che poco alla volta hanno cominciato a includere nelle loro agende e nei loro programmi non solo le rivendicazioni specifiche dell’aborto, ma anche altre rivendicazioni femministe. Tuttavia, nelle pratiche di questa campagna, che ha già 11 anni e va per i 12, è emersa anche la necessità di dare risposte in modo più coordinato alle donne che effettivamente, nel quotidiano, avevano bisogno di interrompere la loro gravidanza.
La campagna si propone come obbiettivo principale la legalizzazione dell’aborto, insieme all’educazione sessuale e alla contraccezione, però sappiamo che, finché la legalizzazione non c’è, noi donne continuiamo ad abortire, e continuiamo a morire, in gran parte le più povere, per aborto clandestino. Quindi hanno cominciato a formarsi quelle che sono le reti di soccoristas, o le soccorristas en red, che sono le donne che danno soccorso. Sono compagne, e anche alcuni compagni, che si sono preparate e si sono costituite in rete, e che rispondono e accompagnano le donne che decidono di interrompere la gravidanza. Si occupano del diritto all’informazione, alla salute, che sono riconosciuti legalmente nel nostro Paese, così come in moltissimi trattati internazionali, e queste organizzazioni di soccoriste sono attive in moltissimi punti del Paese, accompagnano le donne che decidono di abortire.
Nel frattempo si continua anche a dare battaglia sul piano politico: abbiamo letto il documento iniziale che avete condiviso per questa iniziativa, e anche in Latino-America l’aria sa di conservatorismo, e a sua volta di questa combinazione così particolare tra neoliberismo economico da un lato, e conservatorismo sociale dall’altro. Abbiamo misure liberali circa la privatizzazione, la riduzione dei finanziamenti nella salute, nell’educazione, nei programmi sociali, che sono accompagnate da forti alleanze del potere politico ed economico con la Chiesa. La chiesa cattolica, così vicina a voi, ma oggi tanto presente anche in Argentina, con la figura del papa, credo abbia fatto un danno profondo ai movimenti sociali argentini, ma anche altre chiese evangeliche, che hanno un inserimento sociale importante, continuano a costruire un discorso che è penalizzatore, è di colpevolizzazione delle donne. E a sua volta associano fortemente alla donna il mandato materno, in cui la si riduce al ruolo di riproduttrice, di incubatrice, e non di donna piena, desiderante, che potrebbe desiderare o no di avere un figlio. Anche questo si esprime attraverso molteplici misure economiche e politiche da parte dello stato.
Dicevamo che stiamo attraversando un contesto nel quale avvertiamo un’ondata, a livello latino-americano, di governi conservatori. Questo non significa però che abbiamo avuto governi tanto di sinistra o ancor meno femministi prima, però avevano aperto margini in cui la pressione popolare, sociale e dei movimenti sociali, combinata con crisi economiche precedenti, molto forti, avevano fatto in modo che questi governi avessero bisogno, per garantire la loro governabilità, quindi la possibilità di seguitare a stare al potere, di dare alcune concessioni ai movimenti, che implicarono la partecipazione di alcune referenti in alcuni movimenti più vicini allo stato. In Argentina in particolare, questo si è manifestato in una certa quantità di leggi e di iniziative legislative, come è stata ad esempio la riforma del matrimonio civile per includere le coppie non eterosessuali, o la legge sulle identità di genere, pioniera nel nostro Paese, in quanto è una delle poche leggi che non fa dell’identità trans una patologia ma, al contrario, individua l’identità nell’autopercezione, in modo che la persona che vuole modificare il suo genere, nei suoi documenti come nel suo corpo, deve soltanto manifestarlo, senza passare attraverso test o esami medici e psicologici che la definiscono come una patologia, come una malattia. Si sono creati anche i programma “La salute sessuale e la procreazione responsabile”, “L’educazione sessuale integrale”.
Sono tutte iniziative che sono state rivendicazioni storiche del movimento delle donne e femminista, e che si sono plasmate con forza negli incontri nazionali delle donne e nelle loro diverse iniziative in tutto il Paese, e che hanno potuto trovare questa forma, questo riconoscimento da parte dello stato. Questo non ha significato una garanzia piena dell’accesso, però ha significato che da parte del campo popolare abbiamo altri strumenti giuridici per fare pressione per la realizzazione di questi diritti. E in questo senso, come dicevo prima, l’Argentina ha un movimento nazionale di donne molto consolidato: in gran parte si deve all’incontro nazionale di mujeres che da 30 anni esiste e permette alle diverse associazioni di non restare isolate. Noi portiamo avanti in maniera coordinata le campagne e le azioni che in una maniera o nell’altra si riproducono nei diversi angoli del Paese con compagne che spesso non conosciamo, però ci posizioniamo insieme dietro ad alcune rivendicazioni e bandiere, e scendiamo in piazza tutte insieme, lo stesso giorno, a protestare e ad esigere i nostri diritti. Lì è dove si trova anche l’agenda femminista che abbiamo, che parte dall’otto di marzo, il giorno internazionale della donna lavoratrice, però che allo stesso tempo coinvolge il 28 di maggio, il giorno di azione per la salute delle donne, e il giorno dell’orgoglio Lgbt che in Argentina è in novembre e non è in maggio, per una questione di geografia e di temperatura, perché in maggio fa freddo. C’è poi il 28 settembre, il giorno per la lotta per il diritto all’aborto, che è il giorno latino-americano per il diritto all’aborto, che è stato instaurato nel 1990, e da quel momento ogni anno proseguiamo nel rendere più visibile questa rivendicazione, ogni volta con più “massività” e maggiori adesioni.
C’è poi il 25 novembre, il giorno di azione e di lotta contro la violenza sulle donne, in cui ricordiamo anche le nostre amate sorelle miriabal della repubblica dominicana, in questa confluenza con la lotta politica contro la dittatura: sono state assassinate brutalmente per il loro carattere di donne irriverenti, che ovviamente davano molto fastidio al potere. Su questa costruzione storica, e su questa accumulazione simbolica e politica del movimento delle donne, si inserisce la “convocatoria” del 3 giugno, che è emersa nel 2015, a partire dalla necessità di rendere visibili una serie di femminicidi brutali, che realmente hanno creato una sensibilizzazione fortissima a livello sociale, e a maggior ragione in quelle di noi che già dedicano un’attenzione particolare a queste situazioni, e che hanno dato luogo a una convocatoria massiva per il 3 giugno dell’anno scorso, davvero di una dimensione impressionante, impattante, che io credo che generò anche molte contraddizioni tra di noi. Così come la massività ha emozionato, e credo che abbiamo avuto la sensazione di un lavoro che dava un risultato, perché il fatto che siano scese in piazza centinaia di migliaia di persone contro la violenza e i femminicidi è il frutto di un lavoro di diverse decadi, allo stesso tempo ha abilitato certe persone, responsabili di molte di queste violenze, che hanno potuto mettersi dietro alla stessa bandiera in maniera molto ipocrita. In ogni caso credo che l’anno seguente, al 3 di giugno abbiamo dato una nuova prospettiva, abbiamo reso più profondo il nostro discorso e le nostre rivendicazioni, e le abbiamo riempite di un contenuto molto più femminista. È stata di nuovo massiva.
In questa costruzione del 3 di giugno, in questa parola d’ordine del “Non una di meno”, che ha attraversato il pianeta e che è stata ripresa in molti luoghi, dopo l’incontro nazionale delle donne di Rosario, di quest’anno, in cui siamo state circa 100 mila donne, e anche a partire dal femminicidio di una ragazza, Lucia, è nata la convocatoria dello sciopero delle donne, che per noi è molto importante a livello simbolico, perché quel che ha fatto è stato mettere in evidenza l’intersezione tra il nostro carattere di donne e di lavoratrici, e ha portato alla luce l’invisibilizzazione storica del lavoro delle donne, tanto dentro la casa come il lavoro retribuito e sottovalutato, in generale. Quindi questa rivendicazione come donne, ma anche come lesbiche, come trans e travestite, come lavoratrici invisibilizzate e violentate è per noi davvero molto importante, accompagnata anche da questa decisione di vestirci tutte di nero, che pure ha generato dubbi all’inizio, e che però ci ha permesso, durante tutto quel giorno, il 19 di novembre, di riconoscerci. Perché una prima di andare alla manifestazione o allo sciopero, andava a lavorare, a fare lezione, etc, e quando usciva in strada, incontrava un’altra vestita di nero, e si creava una complicità che non necessitava quasi di parole, però ci faceva riconoscere in questa protesta.
Ecco, questo credo sia stato molto forte: ci siamo sentite molto felici di come si è moltiplicato in diversi luoghi. Una settimana fa parlavo con una compagna colombiana, e anche loro si stanno mobilitando moltissimo contro i femminicidi, perché appena giorni fa hanno sofferto il femminicidio e l’abuso di una bambina di sette anni, Giuliana, e lei mi raccontava che in Colombia hanno reagito in qualche modo prendendo come riferimento il “Non una di meno” argentino, e di come rapidamente c’è stata molta reazione. Hanno riconosciuto in questa forma di risposta tanto di questo esempio che si è generato a partire dalla pratica argentina, ed è bello che tra diversi Paesi e tra sorelle e popoli possiamo condividere questa pratica, e anche questo è qualcosa di molto forte da condividere con voi. In relazione a questo c’è una terza caratteristica che ha il femminismo latino-americano: noi diciamo che il nostro femminismo è antipatriarcale, ovviamente, ma deve anche definirsi anticapitalista e anche come anticoloniale. La nostra “via gialla” è segnata dalla ferita della conquista, che non fu solamente una conquista economica, ma anche la violazione del territorio e dei corpi delle donne, e in questa violazione brutale si generarono anche dominazioni nuove e nuove oppressioni.
Per questo la nostra pratica femminista, nella nostra militanza, inevitabilmente deve essere legata anche alla nostra pratica anticapitalista e anche anticoloniale. In questo senso noi donne, lesbiche, trans, travestite, abbiamo preso sui nostri corpi moltissime lotte, che oggi hanno a che fare in gran parte con le lotte contro l’estrattivismo, contro questo modello economico che in realtà di nuovo non ha nulla e che continua a cercare di estrarre la ricchezza dai beni comuni, anche a costo della vita umana e della vita in generale di questi territori, costringendo a spostarsi e cacciando intere comunità, popoli, di fronte ai quali quelle che si sono opposte e che hanno esposto i loro corpi sono state in primo luogo le contadine, le donne dei popoli originari, che sono uscite a difendere il loro territorio, i loro fiumi.
A questo proposito bisogna parlare oggi di Berta Caceres, che è stata assassinata il due di marzo per essere stata la referente della lotta contro la diga e la referente in consiglio civico delle organizzazioni popolari e indigene dell’Honduras. Berta ha esposto il suo corpo di fronte all’installazione di basi militari in Intibucá, nella sua zona, nella sua regione e per il suo popolo Lenka, ed è stata in prima linea con la sua presenza e il suo corpo per il suo popolo, e per questo ha perso la vita. Ieri ricordavamo in un programma radio che, se uccidendola speravano che l’avremmo dimenticata, hanno ottenuto l’effetto opposto, perché oggi molte più persone, in tutto il mondo, sanno chi era Berta Caceres, e se non lo sapete, cercatelo, perché vale la pena di conoscere la vita di questa splendida donna, e come lei ce ne sono molte altre. Per chiudere, una riflessione che per me è vitale, e che è continuare a costruire in rete, e continuare a sostenere il “Non una di meno” in ogni angolo del mondo, con questa idea che, se toccano una, rispondiamo tutte, e crediamo che questo sia di importanza vitale. In questa sorellanza, in questo accompagnarci, sentirci, in questo unire i corpi l’una con l’altra, accumulando questa forza per resistere a tutte le nostre oppressioni.